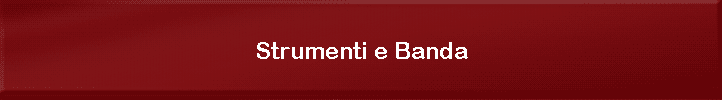
La Settimana Santa a Belvedere Marittimo
Pagine del gruppo spontaneo de "I Fratilli", realizzate e curate da Antonio e Francesco Cuda
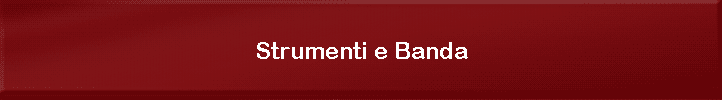
|
Ultimo aggiornamento: 26/03/2024 |
|
|
Nel Centro Storico di Belvedere durante le giornate del Mercoledì, del Giovedì e del Venerdì Santo, si possono ascoltare i suoni provenienti da alcuni "strumenti musicali" molto particolari: tromba, firri, maschitti, tric-trac, tocca-tocca e macinilli.
“Idiofoni di varia forma e natura e di diversi materiali sono impiegati nei riti della Settimana Santa in tutta Europa: sono gli “strumenti delle tenebre”, che prendono vita dal giovedì al sabato, per poi scomparire di nuovo per un intero anno. Deputati a produrre baccano, strepito, suoni scuri e disarticolati, si oppongono, in questo breve periodo dell’anno, all’ordinata e argentina melodiosità delle campane, rese inattive dalla circostanza rituale. Strumenti di legno contro strumenti di metallo, strumenti ad intonazione indeterminata contro strumenti intonati, strumenti “bassi” contro strumenti “alti” […]. Nel quadro dello strumentario italiano di tradizione popolare, tali idiofoni, fra loro correlati dalla comune occasione d’uso, rappresentano degli oggetti sonori dalla grande variabilità morfologica e da lessici locali spesso ambigui, che giustappongono esemplari differenziati e separano esemplari simili, collegandosi anche con ulteriori categorie organologiche e con strumenti-giocattolo." (da “Gli strumenti delle tenebre”. Organologia della Settimana Santa in Calabria di Roberta Tucci).
Diversi sono i significati che possono essere assegnati a tali strumenti:
Ma vediamo come sono costruiti questi strani strumenti.
- La tromba (o trombetta), è una classica trombetta in rame gialla, ma senza pistoni (antecedente al 1767, perché menzionata nel Platea della Congregazione di Maria SS. delle Grazie e Consolazione del notaio D'Alessandro).
"Trombetta di rame gialla servibile alla processione del venerdì santo".
Uno degli storici suonatori della tromba: Salvatore Gaglianone
La tradizione continua da padre in figlio: Vittorio e Luca Gaglianone
L'attuale suonatore: Rosario Bisignani
Ascolta la tromba
- I firri (catene), sono costituiti da almeno due file di catene in ferro a più anelli; gli anelli sono del tipo piatto (ferro battuto) e pertanto i firri risultano essere alquanto rumorosi.
- La tocca-tocca (in italiano, martelletto) è costituita da un bastoncino conico di legno di ca. 20/25 cm. che si allarga nella parte superiore terminando con una forcella. In questa forcella si inserisce, con un perno metallico, un martelletto di legno che batte da un lato e dall'altro una tavoletta di legno nella quale, tramite un foro centrale, va a fissarsi di piatto e dall'alto in basso il bastoncino conico. Il suono rumoroso si ottiene tenendo il bastoncino in mano per l'impugnatura (la parte inferiore più stretta) rivolto in avanti e muovendo la mano velocemente verso destra e verso sinistra, o dall'alto in basso a mo', appunto, di martello.
"Il martelletto (idiofono a percussione) completamente in legno, si compone di una tavola di dimensioni piuttosto ridotte. Su una delle due superfici (inferiore) è infisso, perpendicolarmente, un manico; al centro dell’altra superfice (superiore) uno o più battenti a testa di martello sono incernierati per la base dei gambi in modo mobile. I battenti possono avere forme e livelli di rifinitura variabili: da piccoli, eleganti, martelletti a semplici informi stecche. Impugnando lo strumento per il manico e scuotendolo alternativamente verso destra e verso sinistra, oppure in aventi e in dietro, si provoca la percussione dei martelletti sulla superfice della tavoletta da bande opposte. Generalmente il volume di suono che si ottiene con questi strumenti, in virtù delle loro dimensioni ridotte e dello scarso spessore delle tavole, è piuttosto modesto, anche se non mancano, in alcune aree geografiche, esemplari dalle grandi dimensioni dalle sonorità potenti." (da “Gli strumenti delle tenebre”. Organologia della Settimana Santa in Calabria di Roberta Tucci).
- Il tric-trac, in italiano raganella, è uno strumento musicale a percussione in legno, appartenente alla classe degli idiofoni a raschiamento, che produce brevi e secchi rumori (simili a quelli emessi dai maschi delle raganelle) tramite la rotazione di una lamina flessibile che viene raschiata da una ruota dentata fissata su un manico o su una manovella. Lo strumento, tipico della musica folclorica, è stato utilizzato in composizioni di Beethoven, R. Strauss, Ravel, Respighi, ecc.; viene utilizzato per annunciare i riti e le funzioni religiose durante la Settimana Santa, in particolare dal Giovedì al Sabato Santo, in sostituzione di campane e campanelli. (da Cathopedia e da Wikipedia).
Il tric-trac in uso a Belvedere Marittimo è composto da un pezzo di canna secca (ca. 15 / 20 cm.) incavato a forcella ad una estremità. Su questa forcella si inserisce tramite un foro un sottile bastoncino in salice che, all'estremità da inserire, termina con una ruota dentata di legno (tipo rocchetto e detta carritto) e con un perno metallico per il bloccaggio definitivo sulla forcella. Uno dei due lati dell'incavo della forcella viene lasciato più lungo ed inciso in lunghezza a mo' di stecchetto mobile che viene toccato dal carritto nel suo girare, in modo da essere spostato all'esterno della canna dalla ruota stessa e produrre rumore al ritorno sulla canna. Il rumore si ottiene impugnando con la mano il bastoncino di legno ed effettuando un movimento circolare del braccio che permetta alla canna di roteare intorno alla ruota dentata producendo il suono.
- Una particolare tipologia
della raganella è la traccola (detta anche troccola), raganella dal
meccanismo più complesso ed inserito in una cassa di risonanza, La
troccola è un idiofono a percussione diretta, un tipo di strumenti
musicali popolari composti di una tavola di legno su cui sono installate
delle "maniglie" in metallo. Agitando la troccola le maniglie metalliche
percuotono il corpo in legno producendo un suono caratteristico. La
troccola è utilizzata in processioni religiose e altri eventi della
tradizione popolare dell'Italia meridionale, in particolare nei riti
della Settimana Santa durante la quale è abolito l'uso delle campane.
Serve a rievocare il fragore della terra su cui scesero le tenebre con
la morte di Gesù, in quel buio che avvolge le Chiese, prima della luce
della Resurrezione pasquale. Viene suonata nelle funzioni liturgiche al
posto della campanella, il cui uso è allora escluso, dal termine del
Gloria della Messa nella Cena del Signore, celebrata la sera del Giovedì
Santo, fino all'inizio del Gloria della Veglia Pasquale (da
Wikipedia).
A Belvedere Marittimo la Traccola assume il nome di maschitto. Il maschitto è costituito da una tavola in legno (con una maniglia scavata nella parte superiore per l'impugnatura) dove, sui due lati, sono fissati centralmente due grosse maniglie in ferro (maschitti) a mo' di battente, che battono, sia da un lato che dall'altro, sulla testa di grossi chiodi (tacci) conficcati nel legno. Il suono rumoroso si ottiene tenendo lo strumento in mano con il braccio disteso parallelamente al corpo e girando velocemente il polso in senso orario ed in senso antiorario. Di questi strumenti ne esistono tre antichi esemplari (di cui uno non utilizzabile) conservati nel Santuario di Maria SS. delle Grazie e Consolazione. Dopo la Reposizione del Giovedì Santo pomeriggio e sino alla Veglia Pasquale del Sabato Santo notte, i maschitti sostituivano le campane nell'annunciare l'inizio delle Celebrazioni Liturgiche e nel sottolinearne particolari momenti. Il maschitto è un idiofono a percussione
- Una variante della traccola è il macinillo, lo strumento più diffuso e rumoroso, ma anche il più laborioso da costruire. Di diverse dimensioni, è in legno ed è costituito da una cassetta di legno dalla forma irregolare. Il nome deriva dal fatto che il suono è assicurato dal giro di una manovella che comanda un bastone (posto nella parte più ampia della cassetta) attraversato da una serie di "spine" di legno (da 2 a 4) poste ad intervalli regolari e con inclinazioni diverse. Con il movimento della manovella il bastone gira su se stesso permettendo alle spine di sollevare dei piccoli martelletti (battenti) in legno (da 2 a 4) fissati nella parte più stretta della cassetta, che, nel momento in cui vengono rilasciati, vanno a battere sul fondo della cassetta stessa producendo un suono alquanto rumoroso. Ovviamente, più numerosi sono i battenti e più grande sarà il macinillo con la conseguenza che la cassa di risonanza produrrà un suono più continuo ed intenso.
"Lo stesso ingranaggio della raganella, semplice o plurimo, inserito in un risonatore di legno a scatola, da luogo alla tràccola, strumento di dimensione e sonorità maggiori. Nella tràccola la ruota dentata si espande fino a diventare un cilindro dentato, su cui vanno a poggiare alcune lamelle, eventualmente distribuite su più piani. Il telaio è diventato una tavola su cui sono fissati cilindro e lamelle e che costituisce, a sua volta, la base del risonatore, chiuso e parzialmente aperto. Il cilindro è azionato da una manovella esterna; a volte a esso è collegato un ingranaggio ausiliario di ruote dentate, che hanno la funzione di trasmettere il movimento, alleggerendo la manovella." (da “Gli strumenti delle tenebre”. Organologia della Settimana Santa in Calabria di Roberta Tucci).
L'uso degli strumenti
Gli strumenti in legno vengono usati durante il momento delle Tenebre, la sera del Mercoledì Santo e durante le processioni del Giovedì Santo sera e del Venerdì Santo (mattina e sera). C'è poi l'usanza che allo squillo della tromba, i fratilli facciano rispondere per alcuni secondi tutti gli altri strumenti musicali della tradizione presenti nelle vicinanze: firri, maschitti, tric-trac, tocca-tocca e macinilli; un'altra usanza prevede che, nelle processioni serali, tutti i diversi "strumenti" tacciano all'attraversamento delle Porta Medievale, quando cioè i fratilli si recano alla chiesa di S. Maria del Popolo o quando ne fanno ritorno.
La banda musicale S. Cecilia fu fondata dal maestro Giovanni Polignani nel 1880. La direzione della banda rimase per circa un secolo alla famiglia Polignani: esattamente sino ai primi anni sessanta con il maestro Francesco Polignani. Dopo tale periodo, si è avuto un susseguirsi di diverse direzioni. Dal 1991 è stata trasformata in "Associazione Culturale e Musicale S. Cecilia - Città di Belvedere Marittimo (CS)" e oggi è diventata "Banda Città di Belvedere Marittimo".
La banda è divenuta complemento immancabile delle processioni "belvederesi" del Settimana Santa, in particolare per l'esecuzione della marcia funebre tratta dall'opera "Jone" del maestro Errico Petrella [nato a Palermo nel 1813 e morto a Genova il 1877, coetaneo di Verdi, intorno al 1870 era considerato il maggior operista italiano dopo lo stesso Verdi. Visse a Napoli e scrisse 25 opere. La più famosa è lo Jone, dramma lirico in 4 atti ambientato a Pompei durante l’eruzione del Vesuvio. Di Jone rimase famosa la marcia funebre, tuttora eseguita nel repertorio di molte bande musicali del sud Italia]. Rispetto alla marcia originale del maestro, la versione belvederese si caratterizza per un andamento più lento e solenne e per la presenza di un'aggiunta locale, il cosiddetto "Trio".
Nelle processione serali la banda segue i fratilli e precede le statue e accompagna i fratilli anche durante il "giro dei Sepolcri"; durante la processione di penitenza al Calvario del venerdì mattina si colloca nel mezzo della processione tra la statua de "Il Crocifisso" e quella de "La Bara del Cristo morto".
Ascolta la Banda Musicale S.Cecilia di Belvedere Marittimo nell'esecuzione della Marcia Funebre Jone:
ascolta anche:
La Settimana Santa in Calabria -
Le musiche della Settimana Santa a
Taranto -
|